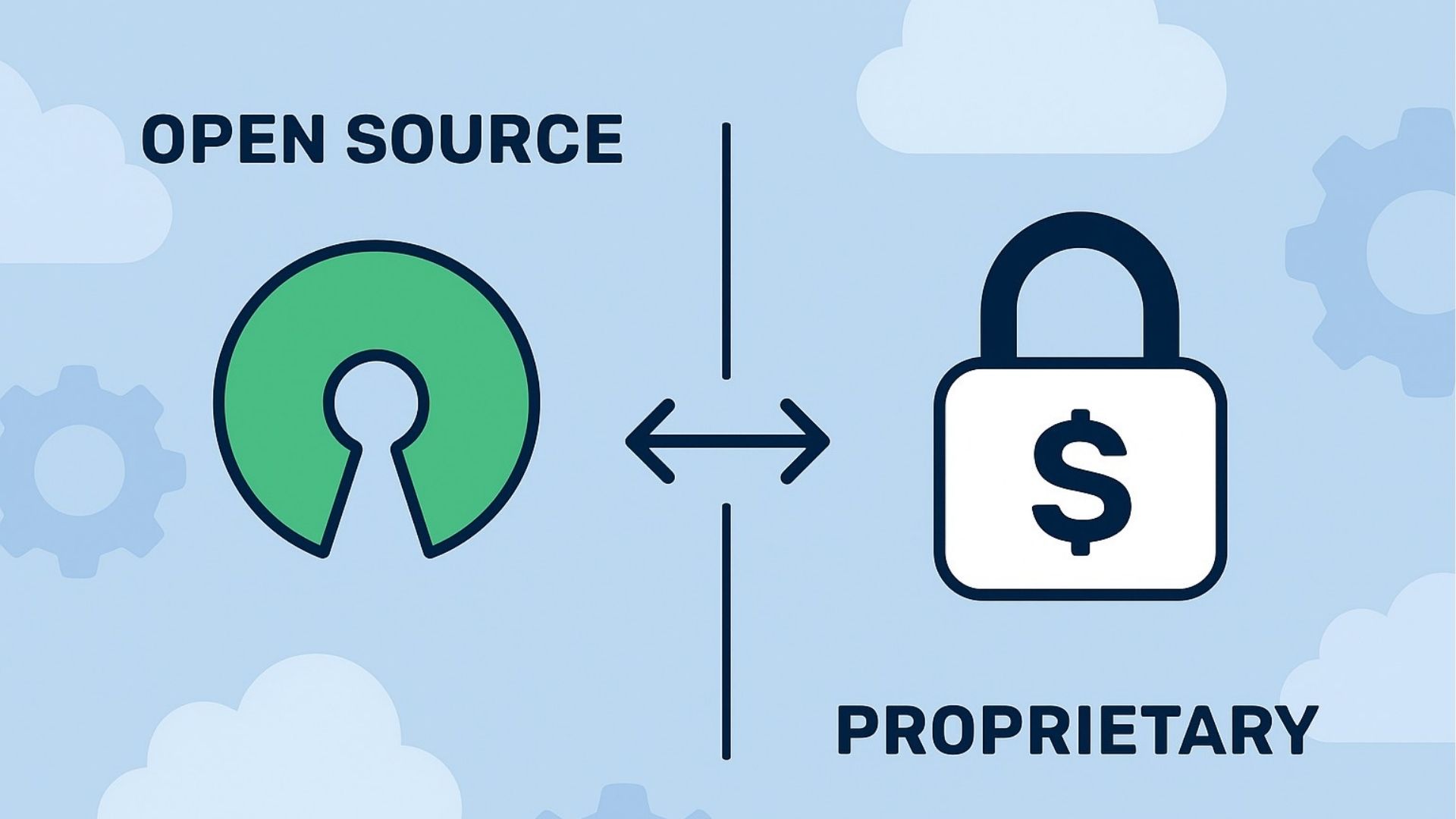
Open Source vs Proprietario: una scelta che riguarda la nostra libertà digitale
Quando parliamo di software, spesso ci concentriamo sulle funzionalità, sull’estetica o sul prezzo.
Ma c’è un aspetto molto più profondo che raramente viene discusso: la differenza tra software open source e software proprietario.
Non si tratta soltanto di una questione tecnica, ma di un tema che tocca la trasparenza, la sicurezza e la libertà degli utenti.
Il termine “open source” ha una definizione precisa, stabilita da organizzazioni come l’Open Source Initiative e la Free Software Foundation.
Un software open source rende pubblico il codice sorgente e permette a chiunque di utilizzarlo, modificarlo e ridistribuirlo.
Questo lo distingue dal cosiddetto “source available”, che mostra il codice ma non concede le stesse libertà.
In altre parole, tutto l’open source è “source available”, ma non tutto ciò che è “source available” è davvero open source.
Questa distinzione è fondamentale, perché la disponibilità del codice non è sufficiente se non è accompagnata da diritti concreti per gli utenti.
La trasparenza offerta dall’open source è un vantaggio enorme.
Quando il codice è pubblico, esperti indipendenti possono verificare che non ci siano pratiche scorrette, come la raccolta eccessiva di dati o l’uso di algoritmi insicuri.
È anche un modo per garantire maggiore sicurezza: vulnerabilità e implementazioni deboli vengono individuate più facilmente.
Un esempio emblematico è quello di LastPass, il noto gestore di password che nel 2022 ha subito un grave data breach.
Solo dopo l’incidente si è scoperto che utilizzava hashing debole e non cifrava gli URL salvati.
Se il codice fosse stato aperto, queste carenze sarebbero state individuate e corrette molto prima.
Il software proprietario, invece, spesso utilizza strumenti come il Digital Rights Management (DRM).
Nato per proteggere i diritti d’autore, il DRM è stato progressivamente trasformato in un mezzo per limitare gli utenti.
Stampanti che rifiutano cartucce compatibili, frigoriferi che bloccano filtri dell’acqua non ufficiali, automobili che offrono funzioni solo tramite abbonamento: sono tutti esempi di come il DRM possa diventare un meccanismo di controllo commerciale.
Persino Amazon ha rimosso libri digitali dagli account degli utenti senza preavviso, dimostrando quanto poco potere rimanga nelle mani del consumatore quando il software è progettato per servire gli interessi del produttore.
Questi problemi si amplificano con l’avvento dell’Internet of Things(https://it.wikipedia.org/wiki/Internet_delle_cose).
Sempre più dispositivi sono connessi: dalle auto agli elettrodomestici, fino alle lampadine intelligenti.
Questo significa che i produttori possono raccogliere dati personali in modo continuo, modificare da remoto le condizioni d’uso e persino bloccare funzioni essenziali.
In un mondo così interconnesso, la scelta di software open source diventa una forma di autodifesa: la comunità può rimuovere limitazioni ingiuste e garantire maggiore libertà d’uso.
Guardando al futuro, la questione non è destinata a scomparire.
Nel 2025 il crimine informatico ha raggiunto costi stimati oltre i dieci trilioni di dollari l’anno, e le vulnerabilità zero-day sono in aumento.
Allo stesso tempo, l’open source sta diventando centrale nello sviluppo dell’intelligenza artificiale, con modelli aperti come LLaMA e Mistral che offrono alternative trasparenti ai sistemi chiusi delle big tech.
Anche la pubblica amministrazione europea sta migrando verso soluzioni open source, come documentato dall’Open Source Observatory della Commissione Europea, per ridurre costi e dipendenze da fornitori esteri.
L’open source non è automaticamente sinonimo di sicurezza o perfezione.
Richiede comunità attive, risorse e governance.
Ma offre più strumenti di controllo e meno spazio per abusi.
In un mondo dominato da IoT e intelligenza artificiale, scegliere software aperto significa difendere la propria libertà digitale e ridurre la dipendenza da pochi grandi fornitori.
È una scelta che riguarda non solo la tecnologia, ma il futuro della nostra autonomia.


